lunedì 24 novembre 2025
Di Avv. Gianni Dell'Aiuto

C’è un paradosso che pochi ammettono ma che ogni professionista serio conosce bene: nel mondo digitale bisogna pensare come se tutto fosse ancora su carta.
Il paradosso della dematerializzazione: la vera compliance non vive di link
Viviamo tra cloud, piattaforme e firme elettroniche, ma la vera conformità al GDPR si regge su un principio antico quanto il diritto: la prova. E la prova, anche nel 2025, parla ancora il linguaggio della carta. Che sia fisica o digitale, poco importa. Quello che conta è che esista, che sia tracciabile e che racconti chi ha fatto cosa, quando e perché. In troppi credono che basti “avere tutto online”: informative caricate in una cartella, nomine inviate via mail, registri compilati una volta e mai più toccati. Ma la dematerializzazione, se non è accompagnata da metodo, è solo una nuova forma di smemoratezza. Il diritto non vive di link, vive di responsabilità. E la responsabilità, per definizione, lascia traccia.
Il GDPR, in questo senso, non è un monumento alla burocrazia, è un sistema di memoria. Ogni incarico, ogni firma, ogni nomina serve a ricordarci che dietro i dati ci sono persone, ruoli, decisioni. La carta non è il nemico del digitale, ma il suo contrappeso. È la garanzia che dietro il flusso di informazioni rimanga un’ombra solida di accountability. Pensare cartaceo significa questo: non stampare tutto, ma ragionare come se ogni azione potesse un giorno finire davanti a un giudice o al Garante. Significa chiedersi chi ha firmato questa decisione, quando è stata presa, su quale valutazione si fonda. Se la risposta è “non lo so, ma è tutto nel sistema”, allora non è compliance: è fiducia cieca nell’algoritmo.
Accountability e memoria giuridica: perché la firma vale più del firewall
Lavorare in digitale ma ragionare in cartaceo significa non dimenticare che ogni scelta amministrativa, ogni valutazione d’impatto, ogni procedura di sicurezza nasce da una volontà umana e da una firma.
Anche quando quella firma è elettronica, la logica resta la stessa: attestare, confermare, assumersi una responsabilità. Senza questi “pezzi di carta” — reali o digitali — il sistema del GDPR si svuota, e la privacy torna a essere una promessa senza prove. È vero che la carta può essere abuso, formalismo, rituale vuoto. Ma può essere anche disciplina, rigore, metodo. È il diario di bordo della responsabilità. Ogni foglio, ogni registro, ogni nomina racconta un percorso di consapevolezza: un’azienda che si interroga, un titolare che pianifica, un DPO che documenta. Il problema non è la carta, ma come la si usa. La carta morta serve a nessuno, quella viva serve a tutti. È viva la carta che viene aggiornata, letta, discussa, usata per migliorare i processi. È viva la carta che diventa memoria di un comportamento corretto e di una scelta consapevole.
Il digitale può essere trasparente solo se qualcuno ne conserva la memoria. E quella memoria, oggi come ieri, si chiama documentazione. Il paradosso è che più il mondo accelera verso l’intelligenza artificiale, più cresce il bisogno di prove umane, di firme, di responsabilità visibili. Perché l’AI può processare i dati, ma non può rispondere a un Garante. Non può dire “l’ho deciso io”. E nel diritto, questo fa tutta la differenza.
Forse è questo il vero insegnamento dei “pezzi di carta” del GDPR: non servono a ingombrare scrivanie, ma a mantenere in vita il principio più semplice di tutti, quello secondo cui chi tratta dati deve poter dimostrare di averlo fatto con coscienza e metodo. È la carta, anche in formato digitale, a dare spessore alla fiducia. È la sua esistenza che distingue un sistema di gestione serio da una collezione di clic. La rivoluzione digitale voleva cancellare la carta. Eppure, quando il Garante bussa alla porta, tutti cercano un foglio da mostrare. Forse non è la carta a essere vecchia. È la nostra memoria digitale a essere troppo giovane.
I 5 errori di compliance che le aziende continuano a fare (nonostante il Garante)
giovedì 8 gennaio 2026
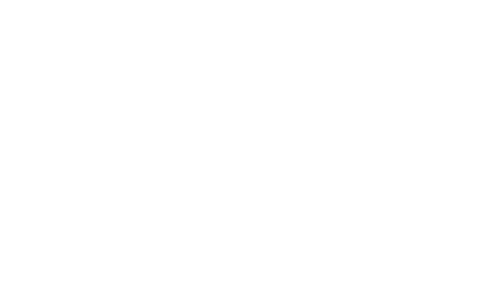 Leggi tutto...
Leggi tutto...

CONDIVIDI QUESTA PAGINA!