lunedì 17 novembre 2025
Gianni Dell’Aiuto
La nuova eredità digitale: il vuoto normativo post mortem
Morire nell’era digitale non è più una semplice questione di successione o memoria. È un problema di gestione dei dati, di diritti che sopravvivono al corpo e di identità che restano attive anche dopo la fine biologica. La privacy, pensata per proteggere il vivente, si trova oggi di fronte a una nuova frontiera: la tutela del defunto digitale.
La rivoluzione digitale ha moltiplicato le dimensioni dell’identità. Ogni persona lascia dietro di sé una quantità di informazioni senza precedenti: profili social, archivi cloud, conversazioni, fotografie, dati sanitari, cronologie di acquisti, documenti in formato elettronico, credenziali di accesso, abbonamenti, identità elettroniche. Tutto ciò che una volta era un lascito materiale – lettere, diari, oggetti – oggi è un’eredità immateriale, spesso sparsa tra server, piattaforme e provider. A cui non si pensa.
Il problema non è soltanto tecnico, ma giuridico e filosofico. Il Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) tutela i “dati personali delle persone fisiche”, ma la sua protezione si estende solo finché il soggetto è in vita.
Esistono altri strumenti; ma sono sufficienti?
Dopo la morte, i dati restano, ma il diritto non li riconosce più come “personali”. È un vuoto normativo che lascia spazio a interpretazioni nazionali e alla discrezionalità delle piattaforme. In Italia, l’art. 2-terdecies del Codice Privacy ha tentato di colmare la lacuna, riconoscendo ai soggetti legittimati (eredi o aventi causa) la possibilità di esercitare i diritti dell’interessato defunto, salvo espresso divieto di quest’ultimo. Ma la norma, pur avanzata, non risolve tutto: perché il defunto digitale non è più solo un utente, ma una presenza.
Diritto all'oblio e immortalità digitale: le sfide etiche e culturali
Le piattaforme social hanno creato una sorta di “vita parallela postuma”. Facebook consente di trasformare un account in “profilo commemorativo”, mantenendo i contenuti visibili ma bloccando le nuove interazioni. Google offre un “gestore account inattivo”, che permette di decidere in anticipo cosa accadrà ai propri dati.
Altre piattaforme, più ambigue, si limitano a congelare gli accessi o a cedere informazioni solo su ordine giudiziario. Il risultato è che milioni di profili continuano a esistere anche dopo la morte dei loro titolari, alimentando un limbo digitale dove memoria, oblio e identità si confondono.
Da qui nasce una domanda centrale per il futuro della privacy: chi è il titolare dei dati dopo la vita? Gli eredi, che potrebbero voler conservare un ricordo? L’azienda che gestisce la piattaforma? O lo Stato, in quanto garante di diritti fondamentali, tra cui quello all’oblio?
La risposta non è univoca, ma la tendenza europea sembra orientarsi verso una gestione etica dei dati post mortem, fondata su tre pilastri: volontà espressa in vita, proporzionalità della conservazione e rispetto della dignità anche dopo la morte. La sfida è culturale prima ancora che normativa. Il concetto stesso di “memoria” è mutato: ciò che un tempo era affidato al ricordo dei vivi è ora archiviato da sistemi che non dimenticano mai. Ma la memoria senza oblio è una forma di condanna. In assenza di un limite temporale, il rischio è che la rete diventi un enorme archivio di identità congelate, incapaci di estinguersi. L’immortalità digitale, che a prima vista può sembrare una conquista, si trasforma in una nuova forma di vulnerabilità: quella di non poter scomparire.
La gestione dei dati post mortem richiede quindi nuove competenze e strumenti.
Digital trust oltre la vita: protocolli aziendali e nuove competenze
Occorre integrare le politiche aziendali di privacy con protocolli dedicati alla “digital death”, prevedendo procedure per la chiusura automatica, la trasmissione o la cancellazione controllata dei dati. Le imprese dovranno sviluppare strumenti chiari e accessibili per permettere all’utente di pianificare il proprio “testamento digitale”. Parallelamente, le autorità garanti dovranno stabilire standard di tutela uniformi, capaci di bilanciare la libertà di autodeterminazione con il diritto alla dignità e alla riservatezza dei defunti.
Ma serve anche una riflessione etica più ampia. La cultura della privacy è nata come difesa dell’individuo vivo contro l’invadenza esterna. Oggi deve imparare a difendere anche l’assenza, il diritto a svanire, a non essere ricordati contro la propria volontà. La protezione dei dati dopo la vita non è solo una questione tecnica: è un’estensione della pietas, un modo moderno di rispettare il silenzio che segue la parola.
Forse la vera frontiera della privacy non sarà la trasparenza dei dati, ma la loro capacità di spegnersi con chi li ha generati. Perché, in fondo, anche nell’era digitale, la dignità umana non si misura da quanto resta di noi online, ma dalla libertà di scegliere se e come lasciare andare la nostra traccia.
In sintesi, avere una Digital trust oltre la vita.
I 5 errori di compliance che le aziende continuano a fare (nonostante il Garante)
giovedì 8 gennaio 2026
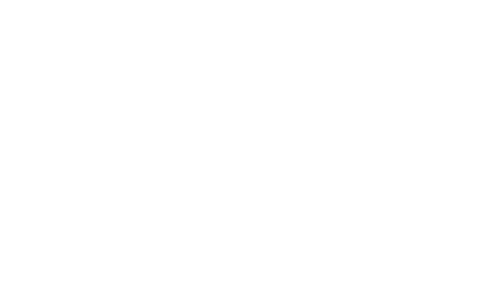 Leggi tutto...
Leggi tutto...


CONDIVIDI QUESTA PAGINA!