lunedì 30 giugno 2025
Di Avv. Gianni Dell’Aiuto

C’è una cosa che i dati non fanno mai: morire davvero.
Lunga vita ai dati
Una volta raccolti, anche se sembrano aver esaurito la loro funzione, restano lì. In attesa. Silenziosi ma vivi. Chi li ha raccolti lo sa, chi li conserva anche. Chi pensa che spariscano con una cancellazione superficiale, sbaglia. I dati, come certi ricordi, non scompaiono. E a volte tornano. Dopo il primo utilizzo, quello che legittima la loro raccolta, molti dati iniziano una seconda vita.
In certi casi utile, in altri borderline, in alcuni decisamente illegittima. Le aziende, gli enti, perfino i piccoli esercenti, si trovano spesso a gestire quantità enormi di informazioni. Alcune necessarie, altre archiviate per abitudine, altre ancora trattenute per pigrizia o per quel pensiero comodo e rischioso che dice: “tanto potrebbero servire”.
Ma cosa si può fare davvero con un dato già usato? La normativa lo consente, purché siano rispettate alcune condizioni. Il GDPR europeo non ha mai vietato l’uso secondario, anzi. Lo ammette, lo regola, lo incanala. Soprattutto se l’obiettivo è la ricerca scientifica, la sanità, l’innovazione. Esistono regole, strumenti di garanzia, e soprattutto una parola chiave: responsabilità. Che non significa solo custodire il dato, ma sapere perché lo si tiene e cosa si intende farne.
Il problema non è la seconda vita in sé, ma il modo in cui viene vissuta. Troppo spesso i dati vengono tenuti in eterno, senza logica, senza informativa aggiornata, senza base giuridica. Il CV inviato per una selezione viene dimenticato in una cartella. Le abitudini di consumo tracciate da una carta fedeltà vengono conservate anche dopo la scadenza. Le e-mail finiscono in un database che sopravvive a sistemi, a responsabili, perfino all’azienda stessa. A quel punto la seconda vita del dato non è più un’opportunità. È un problema.
Potrebbe interessarti > Al gran bazar dei dati personali
La responsabilità non è solo giuridica. È anche culturale. Perché chi conserva dati, conserva persone. Ogni informazione dice qualcosa di qualcuno, e quella cosa, anche se parziale, anche se cifrata, anche se pseudonimizzata, merita rispetto. Tenere un dato significa sapere dove si trova, per quanto tempo rimarrà, chi può accedervi e perché. Significa anche saperlo distruggere quando è giusto farlo. È un nuovo paradigma della complessiva “Cultura d’Impresa”.
In questo scenario si gioca una partita di equilibrio. Da un lato le esigenze legittime di analisi, ottimizzazione, sviluppo. Dall’altro i diritti degli interessati, che non sono solo regole scritte ma aspettative concrete di controllo e dignità. Le aziende più mature sul piano digitale lo hanno capito.
Governare i dati non significa possederli, ma trattarli con consapevolezza. La trasparenza è una forma di potere che rafforza la fiducia, e la fiducia è un asset che non si compra con un banner sui cookie.
Potrebbe interessarti > Dati e responsabilità: quando il GDPR incontra il D.Lgs. 231/2001
La seconda vita dei dati può essere una risorsa straordinaria, ma solo se si conoscono i limiti. Solo se si è pronti a rinunciare all’idea che tutto sia lecito, solo perché tecnicamente possibile. Il rischio non è solo sanzionatorio. È reputazionale, competitivo, esistenziale. Perché ogni dato conservato senza motivo è una mina, e ogni utilizzo fuori contesto è un passo verso l’abuso.
Conclusioni
La tecnologia ha fatto il suo mestiere. Ha reso facile raccogliere, conservare, analizzare. Ora tocca al diritto e alla cultura fare il resto. Dare un senso, un contorno, una direzione. Perché i dati, come le storie, possono essere usati per costruire o per manipolare. E se è vero che la loro prima vita spesso sfugge al nostro controllo, la seconda invece è tutta nelle nostre mani.
I 5 errori di compliance che le aziende continuano a fare (nonostante il Garante)
giovedì 8 gennaio 2026
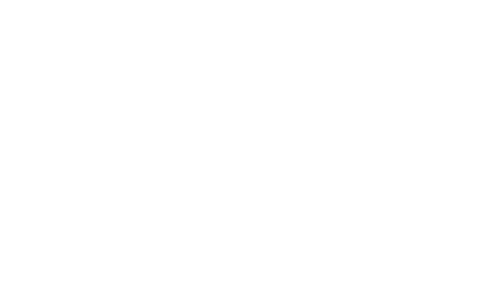 Leggi tutto...
Leggi tutto...

CONDIVIDI QUESTA PAGINA!