lunedì 29 settembre 2025
Di Avv. Gianni Dell’Aiuto

Quando si parla di dati personali ci si concentra sui siti “normali”, dalla banca ad Amazon: Poi passiamo ai social, ad iniziare da Facebook o Instagram, ma la realtà è che il cuore del problema oggi vive altrove.
Oltre i social
Forse è il momento di ripensare diversamente le piattaforme di incontri, nei siti per adulti, nelle app di messaggistica e, sempre di più, nelle piattaforme frequentate da minori come TikTok e Telegram. La differenza rispetto a un gruppo social improvvisato è che qui il consenso c’è, almeno formalmente: si entra dopo aver accettato informative chilometriche e opache, si clicca “Accetto” e si inizia a usare il servizio. Magari dopo avere mentito sull’età, sul nome, sulla mail “ufficiale” e così via.
Dal punto di vista giuridico tutto è corretto: il titolare del trattamento c’è, le policy ci sono, i documenti sono pubblicati. Ma la domanda resta intatta: quel consenso è davvero libero e consapevole, o è solo il prezzo da pagare per poter entrare?
Grinder è stata multata perché condivideva dati sensibili degli utenti con gli inserzionisti senza valido consenso; Tinder è finita sotto indagine per la stessa ragione; OnlyFans ha subito fughe di contenuti e casi di ex-dipendenti con accessi ancora attivi a dati riservati; Bumble è finita nel mirino per l’uso di AI nelle conversazioni. A questo si aggiunge il fenomeno Telegram, diventato rifugio di canali che diffondono illegalmente contenuti rubati, immagini intime, materiale spesso ottenuto senza consenso e destinato a restare online a tempo indefinito.
Potrebbe interessarti > Il rischio di fornire e gestire dati nella App Economy
Il GDPR sulla carta c’è, ma la pratica quotidiana mostra un’altra verità: il consenso non basta a proteggere.
E se per gli adulti almeno si può parlare di scelta, per quanto poco informata, con i minori il discorso diventa ancora più pesante.
Piattaforme e minori: dati sensibili in un web senza difese
Piattaforme come TikTok raccolgono e trattano dati di milioni di adolescenti, con policy formalmente limpide ma nella sostanza costruite per generare profili e preferenze. Già diverse autorità hanno sanzionato TikTok per il trattamento illecito dei dati dei minori, per l’assenza di garanzie reali e per la mancanza di strumenti efficaci di controllo da parte dei genitori.
Potrebbe interessarti > Sanzione Tik Tok: ha violato la privacy dei minori
Eppure, ogni giorno, miliardi di visualizzazioni continuano a produrre dati sensibili sui comportamenti e sugli interessi di ragazzi e ragazze che spesso non hanno gli strumenti culturali per comprendere la portata di quello che stanno cedendo.
Il problema non è la singola app, ma la struttura del web stesso. Il principio del consenso come strumento di tutela si è rivelato un’illusione. La maggior parte degli utenti non legge, non capisce, non ha alternative. Il consenso è una formalità che serve alle piattaforme per dichiararsi conformi, non per proteggere le persone.
E il risultato è che gli adulti finiscono per regalare a cuor leggero dati intimi e identità digitali, mentre i minori si espongono senza alcuna difesa reale a un sistema che non perdona. Il web conserva tutto, e lo conserva per sempre: foto cancellate che riemergono su altri siti, messaggi duplicati e diffusi senza controllo, profili creati nell’adolescenza che tornano a galla anni dopo condizionando vita lavorativa e privata.
La differenza con i gruppi social è solo apparente: lì i dati vengono rubati, qui vengono ceduti. Ma la sostanza non cambia: una volta online, nessuno ti restituirà mai davvero quello che hai dato. E mentre le aziende parlano di compliance e di accountability, la verità è che vivono di un patto implicito e squilibrato, in cui a perdere è sempre l’interessato.
Per gli adulti è una rinuncia, per i minori è una condanna. E se il web è ormai fuori controllo, la domanda non è più se i dati siano sicuri, ma quanto ancora siamo disposti a fingere di credere che lo siano.
Conclusioni
Il punto non è semplice. Come si controllano piattaforme che hanno sede all’estero, che accumulano miliardi di dati e che si nascondono dietro informative incomprensibili? Dove finiscono davvero quei dati, su quali server, in quali mani? Che forza hanno consensi raccolti con un clic, in pochi secondi, senza che l’utente sappia cosa stia accettando? Possiamo davvero chiamarli “consensi formati”, o sono solo finzioni giuridiche che servono alle aziende per continuare a gestire identità, immagini e vite come merce? Finché non si risponde a queste domande, parlare di privacy e di tutela dei dati resta un esercizio di stile.
Dal banco alla banca dati: l’intelligenza artificiale tra mense, app e pubblicità
giovedì 4 dicembre 2025
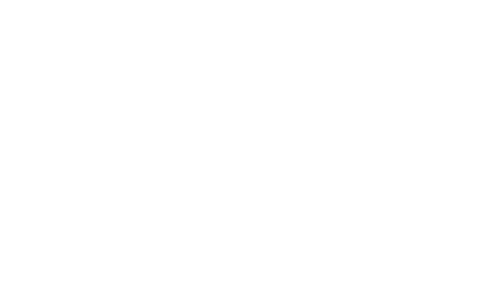 Leggi tutto...
Leggi tutto...

CONDIVIDI QUESTA PAGINA!