giovedì 31 luglio 2025
Di Avv. Gianni Dell’Aiuto

Consumatori: volontari o indotti?
Nel cuore delle città medievali c'erano le botteghe. Piccole, affacciate sulle strade principali o raccolte intorno alle piazze dove, magari, si tenevano i mercati. Offrivano ciò che serviva a chi passava: pane, stoffe, chiodi, utensili, . Non esisteva il concetto di “pubblicità”: al massimo il richiamo del mercante, il simbolo appeso sopra l’uscio, la reputazione che viaggiava di voce in voce. E soprattutto c’era un principio semplice: il commercio nasceva dal bisogno. Si entrava perché si cercava qualcosa. E si sapeva esattamente ciò che si voleva. E' stato così per secoli.
Facciamo un salto negli anni Settanta del secolo scorso, un tempo ancora privo di internet, ma già immerso in un capitalismo maturo. Le strade delle città si popolano di negozi: l’alimentari di quartiere, la cartoleria vicino alla scuola, il negozio di abbigliamento con la vetrina stagionale, la ferramenta che sapeva tutto delle case vicine. La pubblicità era locale: un’insegna, una reclame su un giornale, forse una locandina affissa in bacheca. Carosello, in TV, introduceva la gentile arte della persuasione per i grandi marchi.
È allora — forse — che si comincia a parlare non solo di soddisfare un bisogno, ma di indurlo, stimolarlo, accompagnarlo. L’industria e il marketing iniziano a domandarsi non solo cosa vuole la gente, ma cosa potrebbe volere e come farglielo desiderare. La domanda non nasce più solo dal cliente: inizia ad essere suggerita dal venditore.
Approfondisci > Il consumatore digitale e le implicazioni sulla privacy
Ed è in quel passaggio silenzioso che si nasconde la radice di ciò che siamo diventati oggi: punti mobili di profilazione commerciale, esseri umani attorno ai quali si costruiscono negozi invisibili, personalizzati, predittivi. Se prima si aspettava che qualcuno si fermasse davanti alla TV o ascoltasse la radio, sperando che prestasse attenzione a quello spot, adesso il paradigma è cambiato.
Tu sei la radio. Tu sei la TV. Ti guardi, ti ascolti, e così facendo scegli i prossimi programmi che qualcuno confezionerà su misura, per venderti ciò che tu stesso hai già scelto di comprare.
Sei il terminale di tutti gli input che le aziende vogliono inviarti. E non più inconsapevolmente, ma colposamente, sei tu a chiedere cosa ricevere. Customizzi i messaggi ormai profilati su di te, formuli desideri su misura e, soprattutto, sveli i tuoi futuri bisogni e le tue prossime debolezze.
Sei fulcro, terminale, centro di raccolta, recettore e trasmettitore. Ma sei anche stimolato, osservato, previsto.
Per saperne di più > Al gran bazar dei dati personali
Non sei più solo consumatore. Sei diventato generatore di valore, con i tuoi clic, le tue scelte, i tuoi ritardi, i tuoi scroll. Un essere umano che produce dati a ogni battito d’occhio. E ogni dato è un seme, piantato nel terreno algoritmico dell’economia predittiva. Ma non voglio parlare solo al consumatore digitale. Non solo a chi scrolla, clicca e compra, ma anche a chi, dall’altra parte, progetta, costruisce, analizza, monetizza. Vale a dire a chi gestisce quei dati, li legge, li interpreta, li usa e, troppo spesso, si dimentica che ogni riga in un database, ogni grafico, ogni cluster di pubblico, è un essere umano. Non un ID o una conversione: una persona.
L’essere umano che oggi viene profilato, sollecitato, previsto è lo stesso che dovrebbe essere tutelato. Lo impone il GDPR del resto. Ma dovrebbe dirlo prima ancora l’etica. La correttezza, il buon senso di chi, nel trattare dati, maneggia frammenti di vita. L’uso del dato è uno strumento potente, strategico, quotidiano, quasi meccanico e, spesso disumanizzato.
Conclusioni
Ma gestire dati personali non è come maneggiare viti, fatture o fogli Excel. È un qualcosa che comporta una responsabilità. E chi ci lavora, prima di chiedersi cosa può fare con quei dati, dovrebbe chiedersi se è giusto farlo. Perché sbagliare si può, ma dimenticarsi che si sta usando una persona, e non solo un profilo, non è un errore tecnico. È una colpa. Pensiamoci prima, non dopo che il Garante ha emesso una sanzione.
Creare fiducia digitale oggi, non pezze legali domani è la mission. Ma servono strumenti per farlo e definire una cultura della privacy. Aziende e professionisti hanno in mano grosse responsabilità che vanno oltre i firewall e un disclaimer ben scritto. Chi tratta dati non sta solo facendo marketing o compliance e non lavora solo per la sua azienda, ma per un ecosistema globale. Digitale, sì. Ma pur sempre umano. Cerchiamo di ricordarcene. Prima che siano altri a farcelo notare.
I 5 errori di compliance che le aziende continuano a fare (nonostante il Garante)
giovedì 8 gennaio 2026
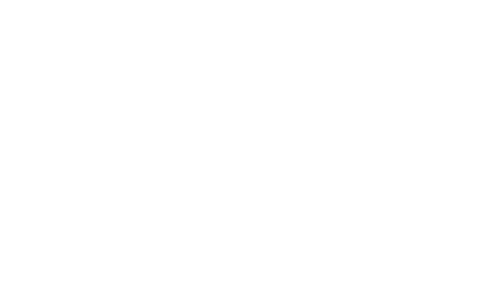 Leggi tutto...
Leggi tutto...

CONDIVIDI QUESTA PAGINA!